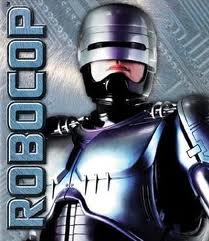Per raccontare gli anni Settanta, la Rai ha chiamato Graziano Diana: il ruolo di «voce narrante» è toccato all’inconsapevole commissario Calabresi e n’è nata una favola sconcia, che ha una morale decisamente immorale: Piazza Fontana come un libro aperto, Pinelli suicidato dal peso di colpe inesistenti e un giudice che assolve davanti alla storia la Questura di Milano. Per Diana, il 1969 è figlio d’ignoti: non ha padre, né madre e, ciò ch’è peggio, nemmeno radici. E’ un mistero glorioso: italiani felici e contenti, Questure strapiene d’amore, incerte tra “Fate bene fratelli” ed esercito della salvezza, poi, va a capire perché, un delirio di bombe, un autunno rovente, manifestazioni a catena e su tutto, inspiegata, la violenza che dilaga.
Per Diana, il 1969 è figlio d’ignoti: non ha padre, né madre e, ciò ch’è peggio, nemmeno radici. E’ un mistero glorioso: italiani felici e contenti, Questure strapiene d’amore, incerte tra “Fate bene fratelli” ed esercito della salvezza, poi, va a capire perché, un delirio di bombe, un autunno rovente, manifestazioni a catena e su tutto, inspiegata, la violenza che dilaga.
Spiace per Diana, ma i conti non tornano. La sua storia degli anni Settanta non la salva nemmeno la libertà dell’arte, che non può fare da alibi a uno stupro della memoria collettiva. Marcello Guida, le stragi, Luigi Calabresi, il fascismo come braccio armato del capitale, non nascono dal nulla, in un 1969 collocato fuori dalla storia e ridotto a un deformante specchio di faglia. Gli «anni spezzati» da Diana sono una forzatura maldestra e pericolosa. Da Portella delle Ginestre a Piazza Fontana corre un fiume di sangue innocente che macchia la storia della repubblica.
Se il punto di vista dell’Italia che ammanettava avesse fatto i conti con quello dell’Italia in manette, la Rai si sarebbe evitata una pagina buia. L’altra “voce narrante”, infatti, quella a cui Diana non ha voluto dare un microfono, ci avrebbe restituito la memoria di un altro Paese. Una memoria che occorre difendere. La «voce» zittita ci avrebbe parlato di un 22 gennaio del 1952 alla Questura di Como, di un collega di Luigi Calabresi che chiede a Scelba «dettagliate informazioni sulla condotta morale e politica di Lionetti Volga, precisando il suo grado di pericolosità per l’ordinamento dello Stato» e tutti avremmo capito che, nonostante la Costituzione antifascista, nel 1952 il fascismo al Ministero dell’Interno non è ancora caduto. Il Questore di Como, infatti, non chiede notizie perché intende perseguire un reato. Sta solo colpendo un diritto conquistato col sangue. La donna, in realtà, ci racconterebbe la voce messa a tacere, è una giovane sarta giunta «a Faggeto Lario per frequentare un corso in quella scuola femminile del P.C.I». Scuola di partito, quindi, e tanto basta alla polizia «repubblicana» ancora perfettamente in linea con le direttive di Mussolini, tanto basta perché non solo il codice penale è e resterà quello fascista, ma la politica è ancora “mistica”, gli uomini del «Duce» sono tutti dov’erano nel ventennio e i linguaggi e i comportamenti, in Questura, trasudano disprezzo per la libertà e i diritti conquistati dai partigiani.
De Gasperi, d’altra parte, è stato molto chiaro: vuole «uno Stato forte» e una «democrazia protetta dagli estremisti di sinistra». Un disegno che mette la repubblica in mano al fascismo moderato e impunito di Scelba. E’ così che – avrebbe spiegato la nostra «voce» – il fascicolo della Lionetti, non a caso figlia di un partigiano combattente delle Quattro Giornate, si aggiunge a quello di Antonio Gramsci, Sandro Pertini e migliaia di antifascisti e militanti del movimento operaio, raccolti in quel Casellario Politico Centrale, ereditato dal regime, che De Gasperi non solo tiene in vita, ma rende più attivo che mai, infilandovi i fascicoli di antifascisti colpiti dalla polizia della repubblica nata dalla guerra di liberazione dal fascismo.
Le notizie su Volga Leonetti si accumulano così con un’alacrità che farebbe arrossire Bocchini e l’efficiente polizia del fascio littorio. E’ un racconto incalzante e rivelatore. Ai colleghi di Calabresi «non consta che la donna sia dotata di particolare cultura, pur tuttavia ella svolge con discreta intelligenza l’attività di propagandista». E poiché nulla nasce dal nulla, spiegano i solerti funzionari, ieri fascisti e ora democratici, non c’è da scherzare: dietro la donna si cela una tradizione di lotta. «In passato», infatti, «i genitori, anch’essi orientati verso il comunismo, tenevano nella propria abitazione conferenze di iscritti e simpatizzanti al P.C.I.» E’ così che l’esperienza dell’antifascismo clandestino diventa, per Volga Leonetti, un pericoloso precedente che la militanza conferma. «Allo scopo di sovvertire l’ordine pubblico sollevando la folla presente», denuncia, infatti, di lì a poco la Questura di Napoli, la donna e «un gruppo di una diecina attiviste comuniste, hanno inscenato una dimostrazione ostile all’arrivo del Generale Rigdway». Non bastasse, scrive il Questore, «invitate ad allontanarsi, hanno insistito nella manifestazione e sono state arrestate, identificate ed associate alle carceri di Poggioreale», a disposizione di giudici e codici che hanno divorziato dalla giustizia sociale e condannano l’operaia a tre mesi di galera. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta, la polizia segnalerà a Roma i «cambi di residenza e […] ogni notizia riguardante Volga Leonetti»: il ruolo che svolge nel Comitato Regionale per la pace, le conferenze per le donne del P.C.I., una condanna e la sua sospensione condizionale ottenuta nel 1955 per reati del 1953, la “denuncia per lesioni, ingiurie e minacce” che nel 1956 finirà in una bolla di sapone. La polizia che anni dopo accoglie Calabresi, presentato da Diana nei panni di un improbabile poliziotto pasoliniano, è la stessa che nel 1958 non ha esitato a rifiutare il «rinnovo del passaporto chiesto da Lionetti Volga, […] fervente attivista e propagandista del P.C.I. ed inscritta al C. P.C. per normale vigilanza».
La donna avrà fortuna. Non volerà da finestre di questure, non si ritroverà in una pozza di sangue, uccisa in piazza, come i 65 compagni caduti in quattro anni, dal 1948 al 1952, o i morti ammazzati a Portella della Ginestra nel 1947, a Reggio Emilia nel 1960, a Ciaculli nel 1963 e ad Avola nel 1968. Il 1969 che la Rai ha volutamente stravolto la troverà, però, tra i 15.000 lavoratori che una legge del 1974 riconoscerà come perseguitati politici nell’Italia repubblicana. E sono numeri approssimati per difetto. E’ questa storia taciuta ad arte a rendere oltraggioso il 1969 e gli anni Settanta di Graziano Diana. Un oltraggio grave, ma rivelatore perché spiega a chi non l’ha ancora capita la tragedia che stiamo vivendo.
Uscito su “Fuoriregistro” l’11 gennaio 2014
![giornalebord[1]](https://giuseppearagno.files.wordpress.com/2013/04/giornalebord1.jpg?w=300&h=214)
![carlo_giuliani_assasinato[1]](https://giuseppearagno.files.wordpress.com/2011/10/carlo_giuliani_assasinato1.jpg?w=500)